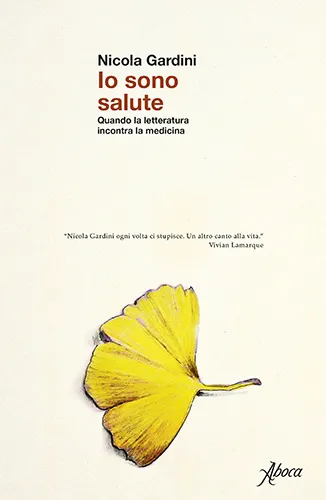Dobbiamo rinnovare la nostra idea di salute. Tutte le nostre idee fondamentali hanno bisogno di rinnovamento, perché il pensiero umano cerca di continuo un grado superiore di felicità, e nessuna definizione è mai definitiva. Dunque, neanche nessun rinnovamento sarà mai ultimo, perché il nuovo non può restare nuovo in eterno. Questo, tuttavia, non deve indurci a credere il vecchio una necessità fatale e costringerci ad accettarlo di per sé. Nessuna società democratica può crescere fatalisticamente. Solo un rinnovamento continuo sarà la risposta.
Non sto parlando di un’ipotesi astratta dell’intelletto. Sto toccando una questione concreta; una faccenda civile e politica, che già si delinea fin dai primi anni di vita nella vita familiare, dove si riceve una prima istruzione sui valori e sui significati. Io per anni ho pensato che la salute fosse il contrario della malattia, perché così mi insegnava la mamma, prima protettrice del mio benessere fisico, e che la salute fosse uno stato primigenio da dover mantenere a tutti i costi, con grande senso di responsabilità, come un tesoro che si fosse ricevuto per magnanima concessione della sorte. Con gli anni, con le esperienze, con l’esercizio della cura (sia di me stesso sia degli altri), ho capito che “salute” significava molto di più. E ci stavano dentro il corpo e l’anima, l’io mio e quello degli altri, il rapporto con il medico e quello con me stesso, l’azione e la parola, la mia storia passata e quella ancora da scrivere.
Le società stesse in cui viviamo sono soggette a trasformazioni inarrestabili – del comportamento e della mentalità – per effetto dei più vari fattori, in primis quelli tecnologici ed economici. Sotto i nostri occhi ogni giorno si riformano anche i concetti più assodati. Pensiamo solo a quali e quante modifiche accadono nella sfera dei rapporti amorosi e nella definizione dei ruoli e degli orientamenti sessuali. La stessa idea di identità è messa in discussione. E così quella di nazione. Quella di straniero. Quella di famiglia… E ciò accade perché sempre più zone dell’esperienza si rivelano degne di osservazione e di considerazione, e alla fine, entrando a pieno diritto nel quadro dei riferimenti obbligatori, modificano i rapporti tradizionali e ne creano di ulteriori, che o si aggiungono agli altri o in parte li rimpiazzano, e quel che sembrava permanente e sicuro e incontestabile appare ormai relativo e passeggero. Tutto è provvisorio e vale solo fino al giorno in cui altro non dimostrerà di valere di più, valendo di più in virtù del semplice fatto di assicurare un maggior grado di felicità agli individui e alla comunità.
Le cose cambiano in meglio non quando si definiscono vicendevolmente per opposizione, ma quando creano ciascuna relazioni complesse con l’intero sistema. Dobbiamo diffidare del paradigma del conflitto (vita/morte, uomo/donna, bianco/nero, giovane/vecchio), su cui da secoli organizziamo non solo il pensiero, ma categorizziamo anche la varietà del mondo, con la tendenza a fare del secondo termine, nella pratica sociale, un concetto negativo (donde la misoginia, il razzismo e molte altre forme di discriminazione). A non è A in quanto non B, ma è A in quanto sta con B e con C e con D e via dicendo. Ciascun elemento del sistema stabilisce relazioni multiple con tutti gli altri, o con la maggior parte degli altri, ovvero partecipa a un tempo alla totalità del sistema e si mantiene in equilibrio con il contribuire all’equilibrio generale. Prendete pure il termine “sistema” per sinonimo di “vita”; e anche per quello di “armonia”. Noi dobbiamo sempre proteggere e aiutare la vita, cioè il complesso delle relazioni, l’interdipendenza delle parti, dove il “tutto” è costituito dai “tutti”.
“La salute è un’intenzione, ce la diamo via via”: Nicola Gardini in video.
Se accogliamo questo modello, che potremmo chiamare il modello della pluralità armoniosa, la salute smetterà immediatamente di rappresentare il termine antitetico di malattia, con cui fin dalla notte dei tempi costituisce un’antitesi. Allora faremo sì che anche un malato possa avere salute; e ci accorgeremo che un sano non ne ha necessariamente una. “Salute” è per ciascuno di noi “voler appartenere al sistema”; “stare nell’armonia”. E questo si farà con la volontà e con il sogno, con la determinazione e con gli ideali, con la solitudine riflessiva e con l’interazione sociale. In salute è chi vuole crescere ancora, nonostante le difficoltà, per quanto ancora sia possibile, giorno per giorno, passo passo, fino all’ultimo respiro, quando anche la fine sarà un traguardo e non un’interruzione. Salute è apertura agli altri; senso dell’amicizia; collaborazione. Amore. Non la malattia, ma la mancanza di amore è la prima negatrice della salute – dove per amore intendo la volontà e la capacità di appartenere all’armonia.
Distinguiamo il concetto di “salute” da quello di “sanità”. Quest’ultimo è standardizzato dalle regole, dai protocolli, da principi generali. Il primo, invece, è personale; è mio e basta: nessuno ne ha ancora parlato, non si trova fissato in punti in alcuna normativa. La salute, infatti, è tante saluti; ognuno ha la sua, e ognuno ne ha più di una nel corso della vita. Ognuno, secondo il momento, si creerà la sua, sano o no che sia. La salute, infatti, è un progetto, al quale ciascuno dedica – o dovrebbe dedicare – tutta la sua vita, che questa termini presto o no, in una malattia o no. Nessuno perde la salute. Nessuno ritrova la salute. La salute è sempre cosa nuova, è sempre “trovamento”. Questo succede sia quando si è sani sia quando si è malati. La persona cosiddetta sana non è – l’ho detto – in salute per definizione. Lo sarà solo se vuole essere in salute: se si impegna a stare costantemente nell’armonia. E la sua salute cambierà negli anni, secondo l’età, secondo le avventure della sua coscienza, secondo le esperienze che le capitano. Lo stesso vale per la persona malata.

Neppure la diagnosi di una malattia grave come un cancro significa fine della salute. Scoperta la malattia o subendo i sintomi della malattia, certo, la persona dovrà cercare un’altra salute. Tuttavia, non ha perduto la salute una volta per sempre. Una salute decade per fare posto a un’altra salute. Occorre molto impegno mentale e occorrono il sostegno degli altri, i familiari e gli amici anzitutto, ma anche i medici. Il sostegno deve esplicarsi nella forma del credito: la persona malata resta una persona; le va, pertanto, ancora riconosciuto il diritto di scegliere per sé. Tutto quello che faremo per lei sarà fatto perché resti lei padrona della sua vita; perché la sua libertà e la sua dignità non siano calpestate. E, quando e se lei non potrà più, sceglieremo noi per lei nel rispetto della sua integrità e dei suoi valori.
I medici, oltre ad assicurare le terapie più utili, possono aiutare in due modi essenziali: 1. provvedendo all’eliminazione del dolore fisico; 2. aiutando la persona a raccontarsi. Al trattamento del dolore fisico, che limita gravemente le forze sia fisiche sia mentali della persona e dunque la sua libertà e la sua dignità, bisognerebbe dedicare una riflessione separata. Qui mi soffermerò sul secondo aspetto. La ricerca di una nuova salute è operazione fondamentalmente narrativa, così come è fondamentalmente narrativa tutta la nostra vita: noi, infatti, ci raccontiamo continuamente a noi stessi e al mondo (l’armonia esiste e può esistere in gran parte proprio nella forma di parole), e proprio per questo riteniamo di avere una vita. Quando ci si ammala, il primo effetto della malattia, avvertita dal nostro corpo o anche solo percepita come diagnosi, non è l’impressione che all’improvviso non abbiamo più nulla da raccontare? Nemmeno la notizia della malattia ci sembra di voler o poter dire, come se la malattia cadesse fuori del nostro racconto. Invece, gli appartiene; gli deve appartenere. Il racconto, infatti, deve andare avanti, perché la nostra vita vada avanti. Dobbiamo solo capire che la storia d’ora in poi seguirà un altro percorso. In fondo, era alquanto presuntuoso credere che la storia – la nostra storia – sarebbe sempre andata come era sempre andata. Non dobbiamo buttare quel che già abbiamo detto: dobbiamo includere nel racconto qualcosa che non avevamo previsto e che si mostra ancora ignoto e minaccioso, e che getterà una luce rivelatrice anche sulla storia già narrata. Anche grazie alla collaborazione del medico, narrarsi elimina il senso di minaccia, perfino quando la malattia non ammette guarigione; rimette d’accordo il nostro passato e il nostro futuro. E, poiché il futuro esiste solo nella forma del desiderio (speranza, aspettativa, illusione), noi dobbiamo tenere vivo il desiderio; vivremo ancora perché desidereremo, perché saremo ancora e nonostante tutto “esseri desideranti”. Quando torniamo padroni della nostra storia, ritorniamo padroni della nostra vita; ritorniamo in salute. Sarà una nuova salute, certo. Ma, come abbiamo detto, la salute è sempre nuova, anche quando sembra che siamo tornati a essere quelli che eravamo prima della malattia. Non è mai così, neppure dopo un raffreddore: la coscienza di noi stessi, dopo una qualunque esperienza, sarà comunque modificata, e se non ne abbiamo coscienza – se cioè non siamo coscienti dei cambiamenti della nostra coscienza –, sarà ben difficile che ci manteniamo in salute. Questo metodo si rivelerà tanto più utile nei casi di malattie gravi. Dove, infatti, non potranno arrivare le chirurgie e i farmaci, là potrà arrivare il nostro racconto: il racconto che il medico ci avrà aiutato a costruire, rendendoci consapevoli di quel che ancora vogliamo e possiamo fare.
Ma i medici sono all’altezza di un tale compito? Alcuni lo sono più di altri, perché hanno la sensibilità e l’intelligenza necessarie. Serve, comunque, una formazione per tutti, che si basi sull’interpretazione dei grandi libri di prosa e di poesia e fornisca una rigorosa preparazione retorica e stilistica. Serve linguaggio: parole, frasi, trame. Serve la capacità di riconoscere le metafore e di farne uno strumento terapeutico. Le parole della persona malata, infatti, arrivano, oltre che nella forma di fatti, anche in quella di immagini e di espressioni figurate, che racchiudono sensi e messaggi riposti. Il medico dovrà stimolare il narratore a diventare consapevole di quei sensi e di quei messaggi, a svilupparli, perché dallo spazio dell’implicito salgano a quello del vissuto e dell’intenzione. Questo ruolo avrà il vantaggio di rendere più creativo il lavoro del medico, e anche quello di dargli la gratificazione poetica che lo aiuti a svolgere felicemente la sua importantissima professione e a migliorare la sua stessa vita.
Io da ragazzo avevo sempre caldo. Stavo in maniche corte anche d’inverno, in casa e a scuola. Non abbottonavo mai il cappotto e non mettevo mai guanti e sciarpa, neppure quando nevicava. Le professoresse, a scuola, mi guardavano disapprovanti e fingevano di rabbrividire. La mamma mi rimproverava: “Ti puzza la salute”. Così si dice nel dialetto di Petacciato, il suo paese nativo (e il mio), quando uno dimostra di non avere abbastanza riguardo di sé. “Vedrai con gli anni…” Lei rimpiangeva di non essersela tenuta da conto, la salute. Aveva cominciato a lavorare da bambina. Le conseguenze apparvero anche troppo presto: mal di schiena, infiammazione muscolare, artrosi… Lei attribuisce ai precoci sforzi dell’infanzia anche la sua bassezza. “E come facevo a diventare alta, se le energie se le mangiava tutte la fatica?” Aiutava la madre in campagna, mungeva le vacche e consegnava il latte di casa in casa. Erano pesanti tutte quelle bottiglie di vetro insieme! Un quartino, in compenso, riusciva a sgraffignarlo, togliendo un po’ di qua un po’ di là, e se lo rivendeva a parte, di nascosto. In Germania, ormai ventenne, peggio che mai. Lì stava in piedi dietro alla pressa, in un calore che rimbecilliva, anche quattordici ore consecutive. Non ridusse il turno neppure quando aspettava il primo figlio, che, guarda un po’, nacque morto. A Milano sottopose il suo fisico a prove ancora più strenue. Aveva in cuore, infatti, di mantenermi fino alla laurea e di comprarsi una casa. Ogni occasione era buona per guadagnare. “Il lavoro mica è vergogna”, diceva. Puliva case e uffici; puliva palazzi interi. La sera, per quanto stanca fosse, tirava fuori i ferri e il gomitolo e faceva maglioni e sciarpe da vendere. Inoltre, faceva iniezioni a domicilio (la gente si complimentava per la sua mano leggera) e qualche pomeriggio alla settimana teneva il figlio della vicina, che tornava tardi dalla fabbrica.
Crebbi con l’idea che mia madre fosse un corpo martirizzato. Lei, per me, incarnava il sacrificio, la necessità stessa del sacrificio. La sofferenza era la sua ragion d’essere: un’autodistruzione gloriosa, uno “star male” ineliminabile e votato a perpetuarsi, a radicarsi sempre più nelle sue fibre e nelle più varie maniere (si aggiunsero nel tempo, oltre ai banali danni dell’usura, anche cisti, calcoli, ernie, colesterolo, problemi cardiocircolatori, pressione alta). Le vicende del suo corpo si sono costituite in una vera e propria leggenda. “Povere mani, tutto da sole avete fatto”, sospirava, quand’ero bambino, e ancora sospira, studiandone gli arrossamenti e le screpolature. “Ah, non siete certo mani da signora!” Oggi quelle mani sono stortissime, bitorzolute, indolenzite, buone solo a svolgere le mansioni necessarie. Vorrebbero, certo, ghermire ancora un paio di ferri o un uncinetto, ma non avrebbero più la forza di stringerli e di guidarli. “Come ho potuto fare tante cose con un filo?” mi domanda, fiera di sé stessa. “Un filo!” sottolinea. Me la ricordo, seduta su una seggiolina, a testa china, che contava i punti e, per non perdere il conto, mi zittiva se solo osavo fiatare, o, dopo un lungo silenzio, individuata la stortura, disfaceva il già fatto e ricominciava, ostinata, stremata, o diceva, compiuta la correzione: “Adesso sì!” Che cosa non avrei dato per alleviare le sue sfacchinate, per non sentirla elencare la sera, prima che andasse a dormire, tutti i fastidi che la tormentavano, per liberarla dal suo destino di pena!
Sono diventato grande nel sogno di regalare al corpo di mia madre il riposo e il benessere; di “restituirle la salute”. E tanto più la credevo martire quanto più confrontavo il suo esempio con quello di mio padre. Lui faceva di tutto per passare da malato; o perfino per ammalarsi, sebbene d’inverno si coprisse di strati di lana fin sopra le orecchie e, quando andava a San Siro a vedere la partita, mettesse sotto al capotto anche un giornale piegato in due per schermare il freddo e d’estate pretendesse di tenere chiuse le finestre durante la notte per non buscarsi un raffreddore. Lui non aveva obiettivi o sogni; non gli importava di comprarsi una casa o di mandarmi all’università. O forse gli bastavano i sogni di lei, sebbene non facesse nulla per favorirli, anzi, facesse il possibile per sabotarli. Bastava che il termometro segnasse 37 perché si mettesse a letto, dove poteva restare
anche una settimana intera. Non si alzava neppure per venire a tavola e pretendeva che il cibo gli fosse servito in camera. Il cuore gli funzionava benissimo, ma si lamentava di continuo di tremendi dolori toracici, convinto che l’infarto fosse imminente. Un’altra cosa che lo ossessionava erano i cosiddetti sbalurdòn, certi capogiri improvvisi. Una volta, colto da fitte a suo dire insopportabili, costrinse la mamma a rientrare a precipizio da Petacciato, dove per una volta era riuscita a far visita ai genitori e alle sorelle. Si trattò di un falso allarme, tanto per cambiare.
(Dal libro di Nicola Gardini Io sono salute. Quando la letteratura incontra la medicina).
La parola “cura”
Nella lingua degli antichi Romani cura non significava ciò che significa oggi, cioè “rimedio”, in particolare quello medico.
Voleva dire “preoccupazione”, “pensiero fisso”, “angoscia”, “ossessione”; perfino “rimorso” e “pentimento”. Ne esiste una vera e propria personificazione nell’oltretomba di Virgilio, unita alle personificazioni di altri terribili disagi, come la fame e la povertà. In questo primo significato torna ancora nella poesia di Leopardi: “e non ti morde / cura nessuna” (Sera del dì di festa); cioè, te ne stai beata a letto, diversamente da me, che non troverò mai pace. Il significato di “cura medica” salta fuori dal senso di “premura” o “attenzione”.
La “cura medica” materializza in prassi un coinvolgimento da principio solo mentale. Nel contesto medico (o ospedaliero o farmaceutico) della negatività originaria non resta nulla: la cura risolve, non abbatte.
“Cura”, per me, significa “attenzione amorosa”. La cura si rivolge al suo oggetto con la precisa volontà di rendergli un qualche beneficio; e implica che il curatore richieda a sé stesso una dedizione e una partecipazione affettiva eccezionali.
(Dal libro di Nicola Gardini Io sono salute. Quando la letteratura incontra la medicina).

Nato nel 1965, Nicola Gardini è scrittore e pittore. Insegna Letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford ed è autore di numerosi libri. Ha vinto il premio Viareggio-Rèpaci 2012 con Le parole perdute di Amelia Lynd (Feltrinelli, 2012). Ha curato edizioni di classici antichi e moderni, tra cui Ovidio, Catullo, Marco Aurelio, Ted Hughes, Emily Dickinson. Il suo saggio Viva il latino (Garzanti, 2016) è stato pubblicato in numerosi paesi. Tra i suoi ultimi romanzi ricordiamo: La vita non vissuta (Feltrinelli, 2015) e Nicolas (Garzanti, 2022). Con Aboca ha pubblicato Io sono salute. Quando la letteratura incontra la medicina. Collabora con il Domenicale del Sole 24 ore, il Corriere della Sera e il Times Literary Supplement.